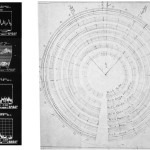1995
Sala Personale al Padiglione Italia dei Giardini di Castello di Venezia
a cura di Gillo Dorfles
opere esposte: Acqua nell’acqua, Musica in gocce, L’offerta, Effimere
Performance di Guido Facchin sui litofoni di A.D.P.
Nella sala personale a terra sono poste 28 gocce in marmo turco per le quali David Ryder ha composto: 28 Stations
performance di Guido Facchin
https://vimeo.com/manage/videos